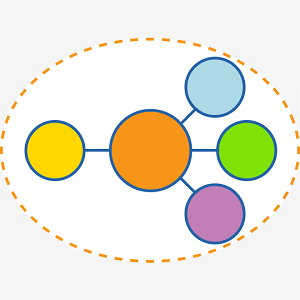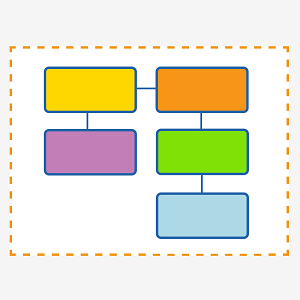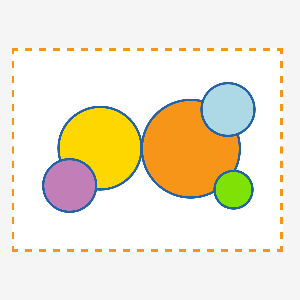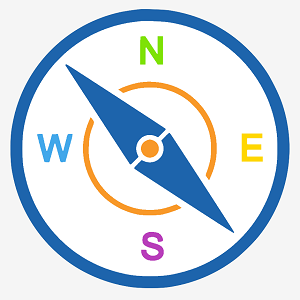Fahrenheit 451

«Sii prudente. Abbi cura della tua salute. Se dovesse succedere qualcosa a Harris, tu sei il libro dell’Ecclesiaste. Vedi come sei diventato importante da un minuto a questa parte?»
«Ma non me lo ricordo più!»
«No, niente mai si perde veramente.»
«Ma ho già tanto cercato di ricordare!»
«Non sforzarti oltre. Ti ritornerà in mente, quando ne avremo bisogno. […] Ti piacerebbe, uno di questi giorni, Montag, leggere la Repubblica di Platone?»
«Ma certo!»
«Sono io la Repubblica di Platone.»
Bradbury, Fahrenheit 451
«Ma non me lo ricordo più!»
«No, niente mai si perde veramente.»
«Ma ho già tanto cercato di ricordare!»
«Non sforzarti oltre. Ti ritornerà in mente, quando ne avremo bisogno. […] Ti piacerebbe, uno di questi giorni, Montag, leggere la Repubblica di Platone?»
«Ma certo!»
«Sono io la Repubblica di Platone.»
Bradbury, Fahrenheit 451
Una sera della settimana scorsa, per caso, ho riletto qualche pagina di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.
L’aspetto che trovo sorprendente di questo romanzo non è tanto la descrizione di mondo dominato dal Potere (visto come una vasta, ma fortunatamente non assoluta, istituzione manicomiale che, attraverso la lesione sistematica della privacy, la “normalità” della professione, della televisione e degli psicofarmaci, demolisce ogni dinamica desiderativa) quanto piuttosto la destituzione di qualsiasi valore feticistico attribuito all’oggetto-libro.
Il libro vale per ciò che contiene, non soltanto per il fatto di essere un oggetto concreto. In Bradbury, il libro torna a connettersi con la funzione che gli è più propria, quella di essere un depositario di memoria che tuttavia non chiede di rimanere inerte, ma di essere rivissuta, di essere nuovamente incarnata, di trovare una voce e un corpo da cui irradiarsi e prendere forma. Si arriva quindi al paradosso per cui gli uomini-libro – gli uomini che incarnano Platone, Swift o Einstein – sono stati i primi a bruciare i propri libri, dopo essersene appropriati attraverso dispositivi mnemotecnici. Essendosi metamorfizzati in essi, non c’è più nemmeno bisogno dei libri. Si dirà che con il loro peregrinare nel buio, al di là della ferrovia che li separa dal Potere, questi uomini-libro ricordano certi peripatetici antichi; qualcuno potrebbe persino sentire in certe loro affermazioni un’eco paolina: “Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me”. Bruciando i libri, Bradbury brucia anche l’idea del feticcio-libro.
Che il rapporto con la verità sia innanzitutto pars destruens ce lo dice tutta la storia della filosofia occidentale (e in effetti, in Fahrenheit 451, il fuoco presenta una duplice funzione: distruttiva, in endiadi con il kerosene, ma nel contempo prometeica, nel personaggio di “Faber”); senza il provvisorio artificio della sospensione del giudizio, senza l’arretramento e il raccoglimento del soggetto di fronte a ciò che si offre al pensiero, difficilmente prende forma l’esperienza originaria del pensare (sia essa la meraviglia di Platone o l’unheimlich di Freud), che si manifesta nella forma dello choc, dell’incontro con il nuovo, con il sorprendente, con l’impensato.
È questa dinamica desiderativa che lo stato totalitario di Fahrenheit 451 cerca di bloccare sul nascere, fornendo ai propri schiavi (attraverso l’imposizione coatta o la propaganda) la perfetta illusione di vivere nell’autentico e, nel contempo, propinando anche la cura dei sintomi e delle sofferenze che la malattia dell’inautenticità necessariamente porta alle proprie inconsapevoli vittime, come la moglie del protagonista Montag. In questo mondo in cui la meraviglia non ha spazio, la parola e il dialogo decadono a banale chiacchiera oppure diventano strumento di delazione; il linguaggio del corpo, il proprio e quello degli altri, si tramuta in una stanca pantomima condivisa con gli sceneggiati televisivi, oppure, nella peggiore delle ipotesi, un singolare geroglifico nel quale ritrovare gli indizi della diversità – e quindi della dissidenza.
Scritto oggi, e non ai tempi del maccartismo, Fahrenheit 451 probabilmente non avrebbe bisogno, per esistere, del kerosene, dei lanciafiamme, di un grande inquisitore (il tremendo personaggio di Beatty), dell’incubo atomico. In certe pagine di Pasolini sul ruolo della televisione e sul compimento delle moderne forme di totalitarismo si può trovare tutto ciò che serve (tra l’altro, anche nel rileggerle silenziosamente, sembra quasi di sentire la voce di Pasolini).
Spesso mi chiedo se il nostro lavoro quotidiano possa spezzare la distinzione e l’alternanza tra professione e tempo libero. Mi chiedo se il passaggio da un luogo ad un altro possa andare oltre l’idea del parcheggiarsi senza sosta, attendendo che sia giunto il momento di andare da qualche altra parte. Mi chiedo se sia possibile che si ritorni finalmente a perdere tempo, e che si faccia del silenzio e del vuoto la dimensione costitutiva e imprescindibile del pensare stesso. Mi chiedo se, di fronte alla polverizzazione dell’esperienza, non sia possibile proporne una che possa produrre una risonanza invisibile, capace di attraversare dimensioni irrelate e sconnesse. Non ho risposte, se non precarie. Ma ritengo che quantomeno gli sforzi debbano essere diretti coerentemente verso questi obiettivi.