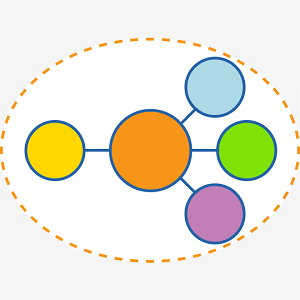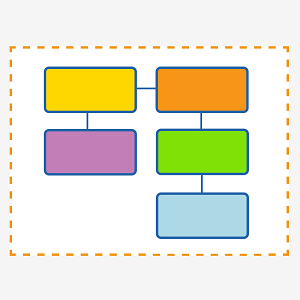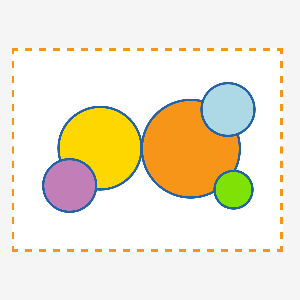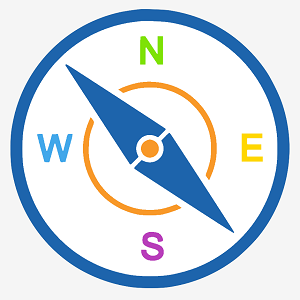Corsivo di Gramellini su Djokovic

Il passaggio che mi ha maggiormente colpito è questo:
Se passeggia in corridoio, incrocia richiedenti asilo e migranti senza visto, per lo più scappati dalla Papua Guinea. Possiamo immaginare le loro facce quando vedono Djokovic. E la sua quando vede loro.“
Gli esiti dell’impossibilità di uscire dalla focalizzazione determinano la grandezza di un’opera letteraria (se ne parla spesso riguardo all’Addio monti manzoniano, forse non abbastanza relativamente ai pantoloni di fustagno di Rosso Malpelo di Verga). Le forme assunte da questo inevitabile “rimanere dentro” al punto di vista possono essere più o meno consapevoli, più o meno meditate. A volte penso che i grandi autori siano proprio quelli che, nel modellare i propri personaggi, siano incapaci di guardarli con il cinismo con cui osservano la realtà intorno a sé, e che a loro deleghino, nella finitezza di creature fittizie, l’evidenza di qualcosa di concluso.A tal proposito, mi colpisce nel corsivo di Gramellini l’esito della trasformazione di Novak Djokovic e dei profughi papuani in personaggi letterari, che avviene nel momento in cui l’autore entra in uno dei corridoi dell’albergo che dividono la stanza di Djokovic da quella di altri rifugiati: non è tanto la descrizione dell’hotel che desta l’attenzione (insetti, larve, lenzuola sporche e anche altro, sulla base delle fonti a disposizione) quanto la passeggiata in corridoio di un Djokovic alla ricerca (volontaria o meno) di una varia umanità, e il conseguente contatto tra lui e altri anonimi rifugiati, e ancora quello strano meccanismo di riconoscimento reciproco che ci sembra di leggere nella ricostruzione letteraria di Gramellini, per cui possiamo “immaginare” le facce dei papuani e del campione nel momento dell’incontro.
Gramellini si/ci salva con l’immaginazione: si toglie, lasciandolo a noi, dall’imbarazzo di raccontare che cosa leggiamo nelle facce dei profughi e di Djokovic. Tuttavia, l’implicito sotteso a questo atto immaginativo non sembra poi così sprofondato nell’incertezza, tanto da apparire più come un sottinteso che come un implicito vero e proprio: i profughi papuani dovrebbero essere meravigliati (e forse anche un po’ compiaciuti?) dalla presenza del campione in quell’albergo, sia per averne avuto notizia dalle fonti di informazione, sia per aver visto un grande movimento nel tugurio in cui sono ammassati in attesa di giudizio; qualcuno di loro potrebbe persino averlo incontrato di persona in una delle sue scorribande in corridoio, noto non luogo in cui ogni osservatore attento definisci scorci antropologici e, più in generale, ciascun essere umano attende incontri stupefacenti; non ci stupiremmo nemmeno, a questo punto, che un giovanissimo rifugiato papuano, avvezzo al tennis sui campi in erba di un esclusivo circolo di Port Moresby, avesse chiesto un autografo a Djokovic, dopo essersi accertato che, sì, proprio di lui si tratta, nonostante la differenza tra l’immagine televisiva e la realtà.
Tuttavia la mia immaginazione – forse diversamente da quella di Massimo Gramellini – non osa tanto. Sono più propenso ad immaginare che l’incrocio di sguardi che potrebbe portare ad un sorprendente riconoscimento fisiognomico (peraltro soltanto unidirezionale) e, ancor di più, ad un riconoscimento che vada giusto al di là del primo (e anche solo per un istante), sia destinato a soccombere alla cecità di due sguardi inconciliabili, ciascuno dei quali guarda ad orizzonti che difficilmente potranno convergere.
Note: l’immagine di Djokovic è presa e ritagliata dal sito Eurosport.it.